Pasquino
[Racconto di Giovanna Gra]
Quando a Roma si parla di Pasquino, si fa riferimento ad una statua che fu ritrovata nella capitale nel 1501, durante il rifacimento della pavimentazione dell'attuale palazzo Braschi. Attribuita allo scultore greco Antigonos, non si seppe mai chi rappresentasse in realtà. Furono fatte diverse ipotesi: per alcuni era la rappresentazione di Ercole, per altri Menelao, per altri ancora Aiace. In realtà, il 'marmo' era molto malridotto per potervi identificare un personaggio preciso. Nella città eterna, tuttavia, questa statua è diventata famosa perché 'parlante'. Qualcuno, un certo Pasquino, appendeva su di essa dei foglietti in rima per mettere alla berlina i potenti che governavano Roma. Pasquino, con i suoi scritti satirici, divenne rapidamente un reale fastidio per le autorità, tanto che papa Adriano VI, intorno al 1520, tentò di far buttare il marmo nel Tevere, gesto che fu poi ricusato perché considerato controproducente. Di fatto, la 'satira del Pasquino' era ormai entrata nel cuore della gente. E così, la statua, scampato il pericolo, continuò a sentenziare senza tema di essere 'zittita'. Attivissima durante il periodo Risorgimentale, tacque, infine, dopo la presa di Porta Pia. Il suo lungo silenzio fu rotto solo nel 1938, durante la visita di Hitler a Roma. Le statue parlanti a Roma sono diverse: Pasquino, Madama Lucrezia, Abate Luigi, Facchino, Marforio e Babuino. Senza dubbio, però, la statua di Pasquino resta la più famosa, tanto da aver dato il proprio nome alla piazza dove campeggia da secoli. Parla Pasquino... Embè? Ahò, e dovete aspetta' 'n momento pe' cortesia e anche 'n po' pe' flemma, si volete parla' der Risorgimento. Cioè, a dire, mo' me classificate agnoste. Nun me guardate ammanco, fate di spallucce ... me cercate d'ignora' e brindate insieme all'oste? Ahò! A popolo: so' ioooo! Nun fa' finta de gnente, nun parla' piano che me conosci eccome.
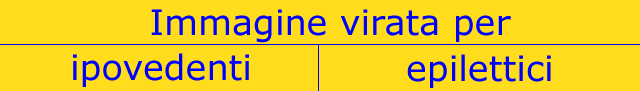
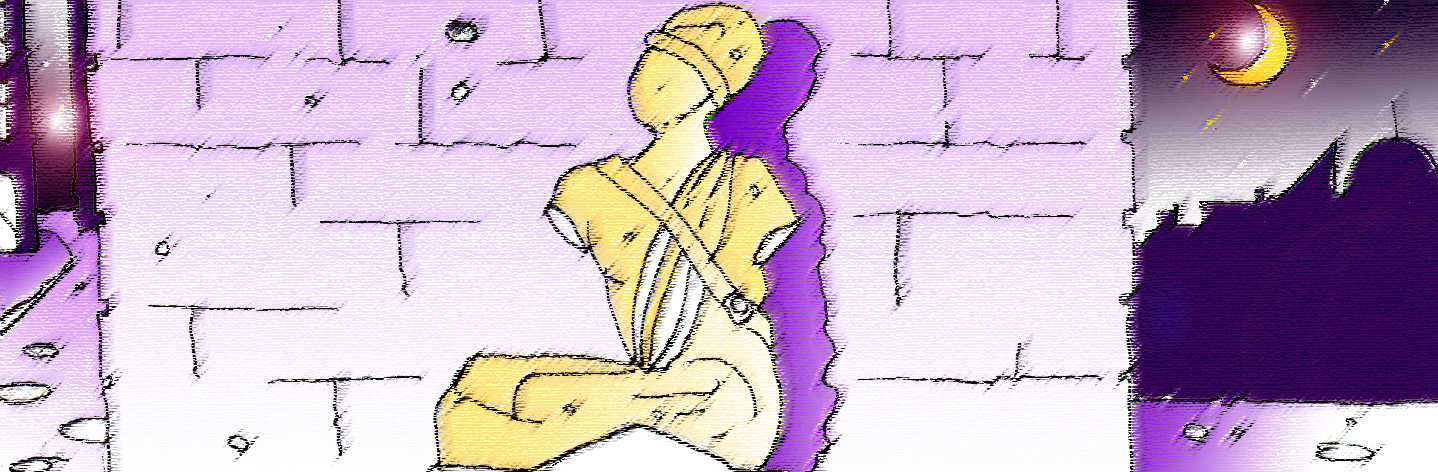









Titoli:
poeta, bastian contrario, birbante de DIO
E già, Pasquino er malefico gabba cristiani,
Pasquino er marmo, quello der Parione,
fiero, immobbile nell'angolo...
dove, oplà, pisceno li cani!
Mbè, è vero quello che se dice, è vero:
smisi di dire la mia.
Bugie vere, false verità,
quanno li bersaglieri entrorno ... la breccia, il varco ... e Pia!
Smisi de parla', de 'nsulta', de fa li conticini
perché me mancò er contraddittore.
Se chiuse fra le colonne der colonnato.
Nell'abbraccio silenzioso e devoto der Bernini.
Ahò, e se Pio se n'era ito,
er tevere scavalcato,
er Pincio colorito...
e anche Garibaldi, zitto, zitto, se n'era ripartito!
Ma qua la storia se sta a ingarbuglia', io vojio racconta' la mia,
dalla nascita der fossile, ossia il sottoscritto,
ar buco der muro, della bella Porta Pia.
Così accadde che nel millecinquecentouno
me disseppellirno alfine, rotto e sbreccato
e nun me riconobbe niuno
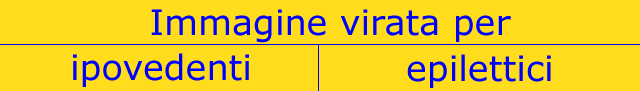










La luna poteva esse calante, er freddo puro era aberrante ... Ma nun era me che staveno cercando, capii all'istante. E, per le cronache, all'opra c'era il Donnino di Angelo Pascuccio, detto il Bramante L'idea era pavimenta' la strada e la faccia de Palazzo Orsini e così, come dei cretini, se trovorno tra la soletta e er pavimento, er volto mio colmo de sgomento! Dissero che ero Menelao o forse Patroclo e ancora er primo che reggeva er secondo, poi me presero pe' Aiace e poi pe' Ercole in lotta. E fra le chiacchiere, me issorno, bastò un semplice colpo de scotta. Alla faccia d'Aiace divenni Pasquino, la statua der crocevia. E incominciai co' le rime, le parole e li versacci a di' la mia. Se diceva der Risorgimento, perché non fui mai de li preti er cocco, raccontatevela come volete cantatevela pure, si credete ma lo strappo andava fatto e puro er tocco. E anche se se dice: fino a San Pietro correje dietro da San Pietro in là, lasciala annà, nun diedi retta al motto e feci fedele la cronaca der patriottico botto. Ma si, er Santo Vecchio fece tutto ammodo creando uno come me che con la satira e la beffa li marmi li corrodo.
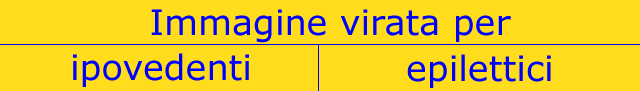










Roma! Ah, Roma mia com'eri bella all'epoca in cui li fermenti attraversavano le tue viuzze piena d'umori, d'amori, de povertà, de pensieri e patriottiche puzze. Nell'anno del signore milleottocento e passa, Pasquino, ar crocevia, infilzò tutti in massa. Gli ingiusti e i prepotenti Co' tutta quella bella consorteria che magna e poi s'ingrassa. Soffiava e fremeva corendo pe' li vicoli garibaldino er vento dei migliori, coi moti drento all'aria indomito e patriota volava er Ponentino. Dice: "Ce la voi racconta' 'sta presa della porta?" Dico: "Prima c'ho n'fatto personale, giacché me fecero 'na storta" Sicché io, no, Poetavo e componevo su quella cornicetta che d'era l'Ottocento, perché su tutte le cose zozze... E me garbava sì, posacce su l'accento! Mannorno due graduati a guardia della statua mia. Basta Pasquinate, Roma! Ordinorno, e così sia.
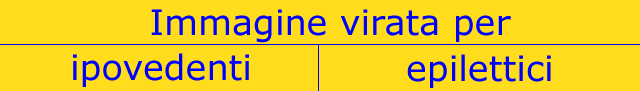
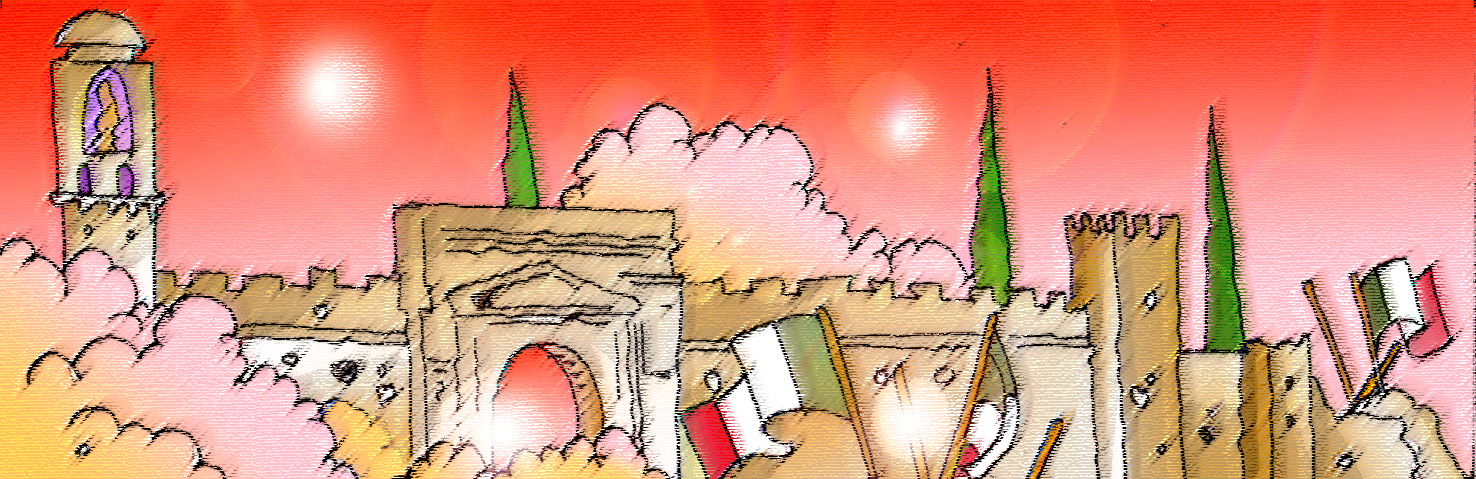









Ma a Roma ne succedevan troppe storte e manco una dritta,
anche se le nostre teste salutorno la pensione dell'affilato Mastro Titta
Ergo, Pasquino pasquinava eccome!
E nostante la mezza, la guazza o la piena luna,
delle poesie i graduati nun ne beccorno una.
Intanto, alla ghigliottina, per il piacere degli oppositori come se avesse senso,
mastro Titta lasciò il posto ar leccapiedi e 'nfame,
Boia per ufficio, Balducci Enzo.
De settembre era l'otto quanno la missiva del re,
dalle mano der conte Gustavo
passò in quelle papaline de Pio Nono che, a lettura avvenuta, certamente sentenziò:
"Me l'aspettavo".
Der papa la parola riferì er Conte, come n'automa:
'Non son profeta,
né figlio di profeta,
ma in realtà vi dico:
non entrerete a Roma'
Sicché, Cadorna, alla guida dei cinquantamila
dall'Umbria con ardore se fece capofila.
Il generalissimo Kanzler, dall'altra parte delle barricate,
n'aveva tredicimila a tenta' il respingimento
pe' fa' poi le gran serrate.
Se aspettorno tre giorni in attesa della resa.
Tre giorni furibondi de arduo combattimento
prima de dichiara' che Roma era stata presa!
Era l'alba, 'n'alba tutta italiana
Er venti settembre dell'anno in cui se fece la buriana.
Er venti, quanno l'artiglieria incominciò la luminaria:
colpì porta San Giovanni, Porta San Lorenzo, Porta Pia
e poi Porta Salaria
Se concetrorno alla fine li bravi bersaglieri
fra Porta Pia e Porta Salaria, coraggiosi e coriacei
italianamente fieri!
Quarcuno descrisse er caso de 'na porta sfracellata
alla zona nord est della città, di una città che mormora
e che fu davvero molto amata ...
Dicheno che trovorno li berretti degli zuavi,
e poi er fumo, la testa delle statue, er chiasso ...
e fra le barricate puro 'n materasso!
Dopo cinque ore in cui parlorno li cannoni,
alle nove der matino,
cedettero di schianto, pace a Michelangelo,
gli stoici muraglioni.
Le nove e quarantacinque scoccorno come 'na freccia
e nella Pia porta se spalancò la favolosa breccia!
Esaltati gli animi nella baraonna della gioia,
entrorno li bersaglieri a Roma, all'urlo di "Savoia!"
E Roma, co' 'n colpo de campana,
se trovò tutt'un tratto capitale unica, vittoriosa, unita ...
e, finalmente, anche Italiana!
Li sordati der Cadorna,
ragionando come chi er tempo se guadagna,
oltrepassorno er buco, senza cavalli o carri,
usando la pedagna.
Li morti furono cinquantotto:
diciannove li pontifici sopra
e trentanove gli italiani che se trovorno sotto.
Grazie al turbinio de li spari e de li fochi d'artificio,
la breccia, se dice e se mormora
che fu di molti metri.
Quei 'trenta', che misero fine allo stato pontificio.
Davanti alla breccia apparve, tempo a dopo,
omaggio alla storia:
una colonna imponente, segno della vittoria.
Opera dello scultore Giuseppe Guastalla,
quella nike ch'aregge la palma e i fasci dell'unità nazionale,
mo v'avverto: nun mancate de guardalla!
Qui finisce la storia mia.
Presa Roma, filai via.
Basta Pasquinate, versi e boccacce,
feci perdere ogni cosa e, per prima, le mie tracce.
Co' tutto st'affannasse me venuto er fiatone,
diamine che fatica fa' la rivoluzione!
Chi se nasconne dietro Pasquino er poeta?
In tutta la città lo domandorno.
C'è chi rispose in tralice,
chi 'nvece era 'nalfabeta.
Quarcuno disse:
dietro Pasquino se nasconne er Belli!
Ma, dico io: a Roma che je frega?
Semo tutti fratelli!
Comunque, pe' la cronaca e pe' l'ignoranti,
Gioacchino, bonanima,
la presa de Roma nun la vide.
Je perì davanti.
Però, 'na cosa de lui me piacque tanto ...
e adesso, co' rispetto, ve saluto e ve la canto:
'Io qui ritraggo le idee di una plebe ignorante, comunque in gran parte concettosa e arguta,
e le ritraggo, dirò, col concorso di un idiotismo continuo, di una favella tutta guasta e corrotta, di una lingua infine non italiana e neppur romana, ma romanesca' (G. G. Belli, Introduzione alla raccolta dei sonetti)

