Neutralisti e interventisti
[Racconto di Paola Manoni]
I venti di guerra del 1914 arrivarono in Italia generando due correnti che attraversarono la politica e l'opinione pubblica italiana: i fautori dell'intervento e i sostenitori della neutralità del Paese, dichiarata al sorgere del conflitto.
L'Italia si trovava a dover scegliere tra diverse possibilità anche se, in linea puramente teorica avrebbe potuto mantenersi nell'alleanza con L'Austria e la Germania e dunque fare ingresso nel conflitto a loro fianco.
Per quest'ipotesi può valere per tutti il commento di Salandra convinto che in tal caso l'Italia, se tra i vincitori, sarebbe divenuta al massimo, "il primo vassallo dell'Impero".
Parimenti il Re Vittorio Emanuele III, in modo più prosaico, scrisse agli ambasciatori a Vienna e Berlino che "non ci sarebbe né il desiderio né l'interesse di attribuirci compensazioni adeguate per il sacrificio che sarebbe stato necessario sostenere".
Un'altra possibilità per l'Italia poteva consistere nel proseguimento della neutralità.
La neutralità corrispose di fatto alla politica condotta dal governo italiano, guidato da Antonio Salandra, nel periodo fra l'ultimatum austriaco del luglio 1914 alla Serbia e la dichiarazione di guerra italiana all'Impero austro-ungarico, del maggio 1915.
Ma nel caso del proseguimento della neutralità, qualora vi fosse stata la vittoria tedesca sul fronte francese, l'Austria avrebbe conservato Trento e Trieste, imponendo la propria egemonia su tutti i Balcani e precludendo all'Italia ogni espansione commerciale e militare.
Oppure si sarebbe potuta attuare una neutralità negoziata mediante un eventuale atto di non belligeranza in cambio del Trentino, nel caso di vittoria tedesca
Infine l'altra opzione: l'intervento in guerra a fianco delle Triplice Intesa.
L'ipotesi degli interventisti consisteva nel rivolgimento delle alleanze e nell'entrata in guerra a fianco della Triplice Intesa.
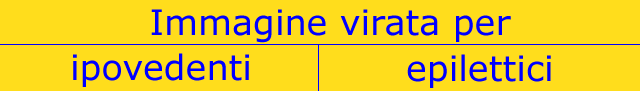
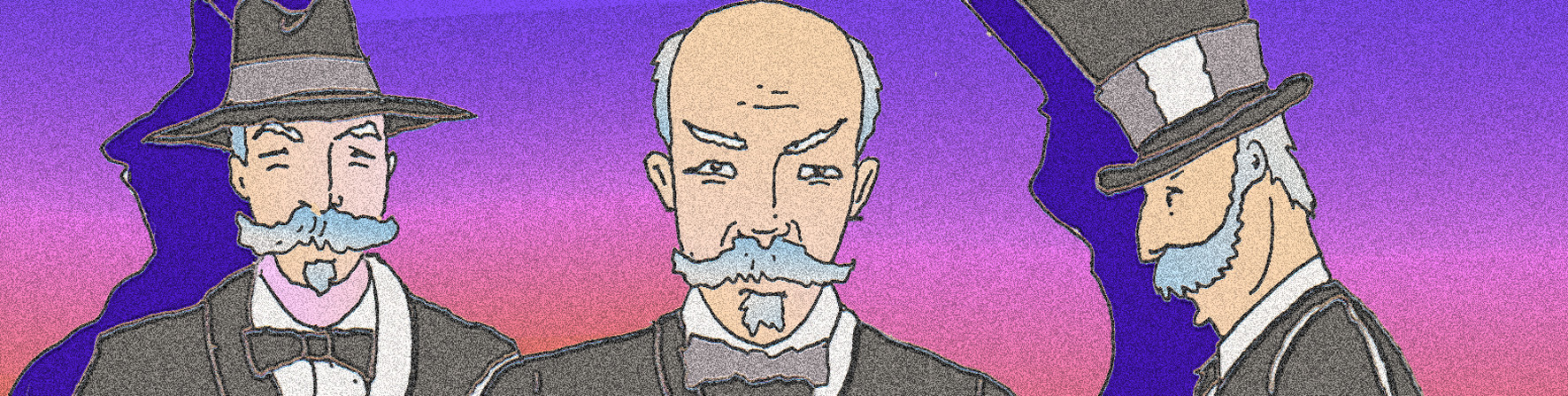










Ma tale possibilità era comunque subordinata a un'azione diplomatica con l'Austria per far cadere il precedente trattato di alleanza nel caso in cui Vienna non avesse mostrato la disponibilità a fare concessioni all'Italia.
La possibilità di restare neutrali si agganciava all'interpretazione dell'articolo 7 della Triplice Alleanza (trattato che univa l'Italia alla Germania e all'Austria) il quale stabiliva l'obbligo di aiuto reciproco solamente nel caso di aggressione da parte di una o più potenze.
Le trattative per l'applicazione dell'articolo 7 fallirono e l'Italia denunciò nel 1915 la violazione dei patti con la conseguente rottura della "Triplice" da parte dell'Italia. E l'ingresso dell'Italia in guerra avvenne con la dichiarazione di guerra all'impero Austro-Ungarico.
Ma da un più articolato punto di vista, i passaggi che vedono l'ingresso dell'Italia a fianco delle potenze dell'Intesa, attraversano diverse fasi e schieramenti politici nonché una forte propaganda giornalistica e sociale che accese lo scontro tra le parti pro e contro la guerra.
Gli interventisti si rifacevano al concetto di unità nazionale da portare a compimento con gli ultimi lembi delle "terre irredente" - il Trentino e Trieste.
I neutralisti consideravano le scarse risorse economiche e militari per sostenere il conflitto.
Ma era in ogni caso condiviso il timore che l'ultimatum dell'Austria alla Serbia potesse comportare il realizzarsi di un disegno egemonico asburgico in tutta l'area adriatico-balcanica.
Le posizioni degli interventisti oscillavano fra la considerazione di una vittoria dell'Austria come foriera di indebolimento dell'Italia e la valutazione di una vittoria dell'Intesa (con la neutralità dell'Italia) che avrebbe portato un riassetto europeo postbellico dove l'Italia sarebbe rimasta fuori gioco.
Nella corrente dei neutralisti si annoveravano:
I socialisti italiani, i quali rifiutavano la guerra voluta dalle grandi potenze europee imperialiste e capitaliste.
Ma di fatto l'interventismo dei socialisti europei indeboliva la posizione nazionale;
La compagine cattolica che seguiva l'orientamento dato dal pontefice, forte sostenitore della pace.
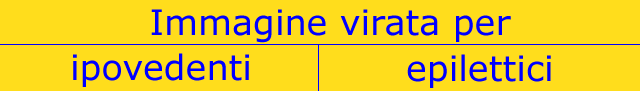
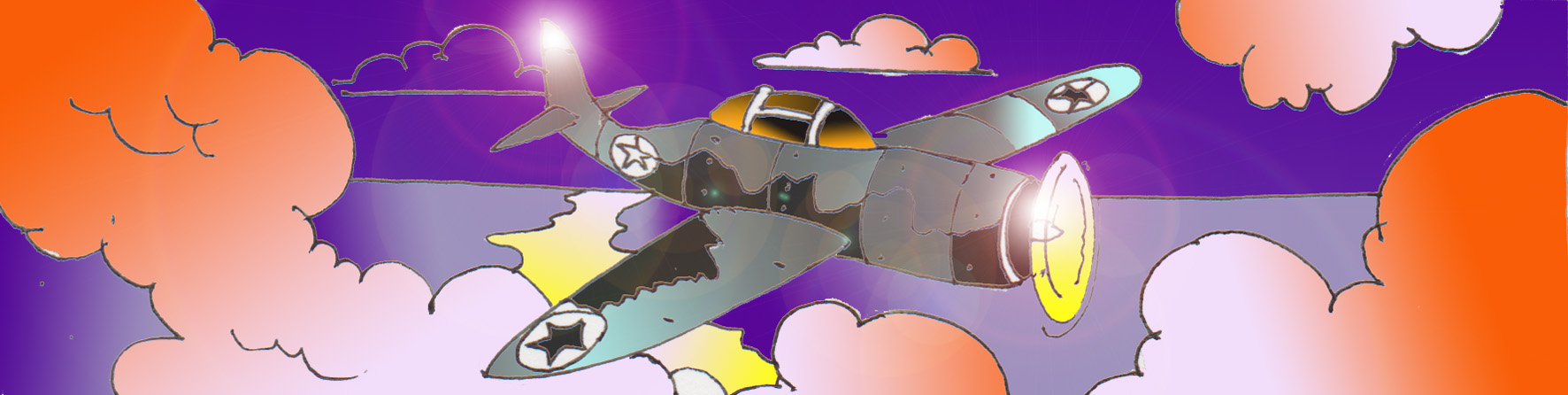










Tuttavia, il neutralismo per fedeltà alla Chiesa in molti casi andava in contrasto con l'adesione politica a forze interventiste;
i Giolittiani, i quali sostenevano che l'Italia non poteva sostenere una guerra lunga e dispendiosa senza risorse economiche e militari. Giolitti, aveva lasciato Presidenza del Consiglio ma era ancora molto influente per il sostegno alla neutralità italiana.
Convinto dell'azione diplomatica come mezzo pacifico per riavere dall'Austria i territori italiani, Giolitti pensava di contrattare la neutralità come se fosse una vittoria.
Nella corrente degli interventisti, amplificata dalla propaganda della stampa, (ad esempio: Corriere della Sera, Domenica del Corriere, Idea nazionale) si riunivano diverse fattispecie:
i liberali conservatori sostenevano l'intervento in guerra quale occasione per bloccare le riforme giolittiane, per ottenere i territori del Trentino e Trieste, per dare un nuovo prestigio al parlamento italiano.
I "socialisti riformisti", la sinistra massimalista italiana, i quali sostenevano l'importanza della sconfitta degli imperi centrali come via di uscita per la costruzione dell'indipendenza nazionale e per la costruzione di un'Europa democratica.
se tra questi è ben conosciuta l'adesione di Mussolini, risulta invece meno noto il coinvolgimento di Togliatti, volontario negli alpini, e di Gramsci.
Quest'ultimo, ad esempio quando Mussolini, il 24 ottobre del 1914, pubblicò sull' Avanti! (di cui era direttore) l' articolo che preannunciava la svolta con il titolo "Dalla neutralità assoluta alla neutralità attiva ed operante". Gramsci scrisse per il Grido del popolo un articolo a sostegno delle tesi di Mussolini nel dibattito sulla guerra.
Gli "interventisti democratici" i quali sostenevano la richiesta all'Austria della cessione delle terre irredente.
Il movimento dei nazionalisti sosteneva un ideale imperialista secondo cui la partecipazione alla guerra avrebbe premiato le ambizioni espansionistiche.
Come ricordato, l'entrata in guerra dell'Italia fu determinata dall'uscita dalla Triplice Alleanza. Il ministro degli esteri San Giuliano tentò di negoziare la posizione neutrale fin dall'agosto 1914 ma non emerse una via percorribile: l'Austria non considerava alcuna compensazione se l'Italia non fosse entrata in conflitto, interpretando la dichiarazione di guerra russa all'Austria-Ungheria come un Casus foederis.
Ma tale posizione era contraria al trattato e controproducente poiché l'Austria aveva interesse a tenere l'Italia fuori dalla guerra: considerava le prime vittorie delle battaglie tedesche e valutava ancora possibile una rapida soluzione del conflitto.
Alla morte di San Giuliano, nell'ottobre 1914, Sidney Sonnino prese il dicastero degli esteri il quale intendeva approfittare della guerra per "spazzare via il parlamentarismo italiano" e dunque si adoperò per favorire le correnti interventiste.
Luigi Cadorna, capo dell'esercito italiano, nonostante l'arretratezza delle forze militari della nazione, dal canto suo riteneva sufficienti le armi a disposizione per una partecipazione al conflitto mondiale.
Egli nel 1914 semplicemente dichiarava:
"La bilancia è oggi oscillante e piuttosto a sfavore degli Imperi centrale.
Se un altro esercito viene gettato sul piatto avverso, dovrebbe traboccare".
Il processo con cui l'Italia firmò a Londra, con la complicità del ministro degli esteri Sidney Sonnino, nell'aprile 1915, il patto segreto per l'alleanza alla Triplice Intesa fu un lungo mercanteggiare.
Il patto di Londra sanciva che in caso di vittoria l'Italia avrebbe ottenuto il Trentino e Trieste, l'Istria, la Dalmazia, il porto di Valona e altri territori da stabilire.
Il Re si dichiarava a favore della guerra senza avere ancora l'approvazione del Parlamento.
L'opinione pubblica, con la propaganda interventista, manifestò l'ardore di combattere per la patria.
Il discorso celebrativo che D'Annunzio pronunciò a Quarto il 5 maggio 1915 (per la commemorazione dei Mille) cosi come la sua arringa in favore della guerra tenuta a Roma il 13 maggio 1915 scatenarono entusiastiche manifestazioni interventiste.
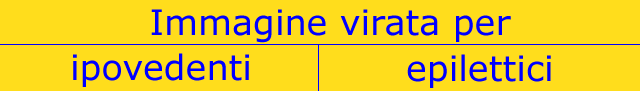











Ma nonostante la propaganda, rimaneva il problema di convincere il parlamento di maggioranza giolittiana ad entrare in guerra.
Il primo ministro Salandra rassegnò le dimissioni.
L'ex premier, l'anziano Giovanni Giolitti venne convocato a Roma ma al suo orecchio arrivò la notizia del patto segreto di Londra.
Giolitti allora rifiutò l'incarico di formare un nuovo governo e il Re si trovò agevolmente nella situazione di rifiutare le dimissioni di Salandra.
Si trovano molte testimonianze dell'atteggiamento tortuoso di Salandra verso Giolitti nei mesi precedenti la dichiarazione di guerra del'Italia.
Una valida voce fu quella alzata da Olindo Malagodi, amico devoto di Giolitti (senza tuttavia condividerne le idee neutraliste).
In un suo libro, purtroppo dimenticato dalla storiografia, dal titolo Conversazioni della guerra 1914-1919 , egli afferma che Giolitti ebbe fiducia in Salandra, di cui solo lamentava la poca abitudine alle trattative diplomatiche, sino a che comprese di essere stato ingannato.
Sicché Giolitti lasciò subito Roma per ritornare in Piemonte.
Il 20 maggio 1915, vi fu al Parlamento l'approvazione del conferimento al governo dei pieni poteri in caso di guerra.
Il colpo di mano del Re era andato a segno.
Vi furono 407 voti favorevoli contro 784 per conferire pieni poteri a Salandra nella scia del fermo atteggiamento del Re e nella direzione delle violente manifestazioni di piazza della gente inneggiante alla guerra.
L'esempio di Milano fu emblematico dove si susseguirono diverse manifestazioni che portarono circa 30 mila persone in piazza a sostegno dell'intervento militare come atto patriottico.
Ma le prime battaglie nei territori del Carso in cui fu coinvolto l'esercito italiano furono disastrose, come testimoniano i diari di tanti soldati anonimi così come degli intellettuali partiti in guerra.
In relazione a questi ultimi, è importante ricordare la loro posizione favorevole nell'interevento dell'Italia in guerra.
Tuttavia dalla penna di molti scrittori tramontò l'ideale interventista del maggio radioso.
La mutata prospettiva presentava quasi esclusivamente gli aspetti tragici dell'evento.
Un esempio emblematico è l'esperienza del poeta Ungaretti il quale partecipò alla campagna interventista, per poi arruolarsi volontario nel 19º reggimento di fanteria.
Egli combatté sul Carso e in seguito e riportò le sue memorie in versi poetici.
Ettore Serra, giovane ufficiale, le fece stampare in 80 copie presso una tipografia di Udine nel 1916, con il titolo Il porto sepolto.
Disse Ungaretti:
"Il porto sepolto è ciò che di segreto rimane in noi, indecifrabile"
E poi ancora su quelle 80 poesie della raccolta egli affermò:
"A dire il vero, quei foglietti: cartoline in franchigia, margini di giornali, spazi bianchi di care lettere ricevute - sui quali da due anni andavo facendo giorno per giorno il mio esame di coscienza, ficcandoli poi alla rinfusa nel tascapane, non erano destinati a nessun pubblico."
La poesia Veglia, in particolare, composta in trincea all'antivigilia del Natale 1915 esprime il carattere privato e disperato della lirica:
Un'intera nottata
buttato vicino
a un compagno
massacrato
con la sua bocca
digrignata
volta al plenilunio
con la congestione
delle sue mani
penetrata
nel mio silenzio
ho scritto
lettere piene d'amore
Non sono mai stato
tanto
attaccato alla vita
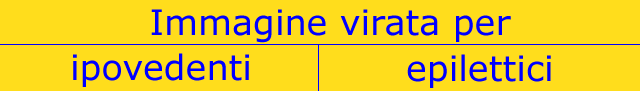











I versi esaltano il dramma dell'approdo alla guerra, della consapevolezza e fragilità della paura della morte.
Ancora un altro esempio emblematico lo fornisce il romanziere Carlo Emilio Gadda.
Convinto interventista e attivista del maggio radioso, allo scoppio della Grande Guerra partì come volontario negli Alpini.
Venne fatto prigioniero nella battaglia di Caporetto del 1917 e poi deportato in Germania.
A seguito di questa esperienza scrisse il Giornale di guerra e di prigionia, raccolta di tutti i suoi diari, dal 1915 fino al 1919 con cui denunciò gli errori di conduzione della guerra.
Ecco alcuni brani significativi:
I nostri uomini sono calzati in modo da far pietà: scarpe di cuoio scadente e troppo fresco per l'uso, cucito con filo leggero da abiti anzi che con spago, a macchina anzi che a mano. Dopo due o tre giorni di uso si aprono, si spaccano, si scuciono, i fogli delle suole si distaccano nell'umidità l'uno dall'altro.
Un mese di servizio le mette fuori d'uso.
Questo fatto ridonda a totale danno oltre che dell'economia dell'erario, del morale delle truppe costrette alla vergogna di questa lacerazione, e, in guerra, alle orribili sofferenze del gelo!
Quanta abnegazione è in questi uomini così sacrificati a 38 anni, e così trattati! Come scuso, io, i loro brontolamenti, la loro poca disciplina! Essi portano il vero peso morale della guerra, peso morale, finanziario, corporale, e sono i peggio trattati [...]
Edolo, 19 settembre 1915
E ancora, chiudendo con le parole del grande scrittore:
Chissà quelle mucche gravide, quegli acquosi pancioni di ministri e di senatori e di direttori e di generaloni: chissà come crederanno di aver provveduto alle sorti del paese con i loro discorsi, visite al fronte, interviste, eccetera.
Ma guardino, ma vedano, ma pensino come è calzato il 5° Alpini!
Ma Salandra, ma quello scemo balbuziente d'un re, ma quei duchi e quei deputati che vanno "a veder le trincee", domandino conto a noi, a me, del come sono calzati i miei uomini. [...]
Asini, asini, buoi grassi, pezzi da grand hôtel, avana, bagni; ma non guerrieri, non pensatori, non ideatori, non costruttori; incapaci di osservazione e d'analisi, ignoranti di cose psicologiche, inabili alla sintesi; scrivono nei loro manuali che il morale delle truppe è la prima cosa, e poi dimenticano le proprie conclusioni.
Edolo, 20 settembre 1915

