In salotto
[Racconto di Paola Manoni]
La casa, come spazio di vita familiare ma anche come fucina di idee rivoluzionarie. Dimora di rango elevato, nella scala sociale, che si intride della priorità sociale del tempo: lo scambio intellettuale, la conversazione, la pianificazione dell'azione come mise en place del pensiero politico. Il cenacolo intellettuale vissuto nelle mura domestiche presso le grandi abitazioni delle città benemerite risorgimentali. Il salotto di Clara Maffei, uno dei più rinomati. Il Risorgimento in casa Maffei. Porte aperte a molti ospiti illustri, viandanti di spicco nel mondo dell'arte e della cultura. Massio D'Azeglio, Ippolito Nievo, Franz Liszt, Giuseppe Verdi, Alessandro Manzoni, per citare qualche esempio. Senza timore di smentita si può affermare che nel salotto della Maffei si decidono i destini dell'Italia. Nei salotti si traccia il profilo dell'Italia. Il problema dell'Unità e della rivolta anti-austriaca si mescola con i temi dell'arte e della musica. La dimensione politica è globale. Il 'divano' diviene la cornice che raccoglie e integra i diversi saperi. La padrona di casa è l'artista del ben ricevere e offre la sua casa come 'il centro' di un ordine di idee civili, liberali. Clara Maffei è una gentildonna: nell'aspetto e nel conversare. Occhi bruni, belli e meditabondi, a volte velati da malinconia. Sempre piena di attenzioni verso gli altri, dove il detto manzoniano: "Chi molto ama non ha tempo di odiare" sembra pensato per lei. Ma una delle sue migliori qualità è la riservatezza. Sa mantenere il segreto e i suoi amici lo sanno bene. Depositaria ad esempio dei segreti di Giuseppe Verdi che sovente conclude nelle sue lettere: "... lo dico a Voi: non ditelo a nessuno".... E' così! Clara, nata nel 1814, ha origini nobili. Figlia dei conti Carrara Spinelli (storica famiglia bergamasca). Suo marito, Andrea Maffei, è poeta - titolo purissimo, d'altra genealogia. Ma è dalla famiglia di sua madre (i nobili Gambara di Brescia) che Clara eredita uno spirito libertario. Tra i suoi parenti, vi è quel conte Francesco che si infervora di ardore giacobino e guida un'orda di bergamaschi e bresciani rivoltosi che insorgono, contribuendo a consegnare nelle mani di Napoleone la Repubblica Cisalpina.
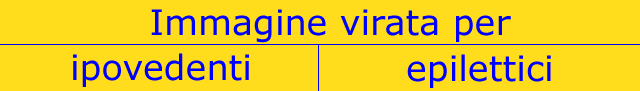
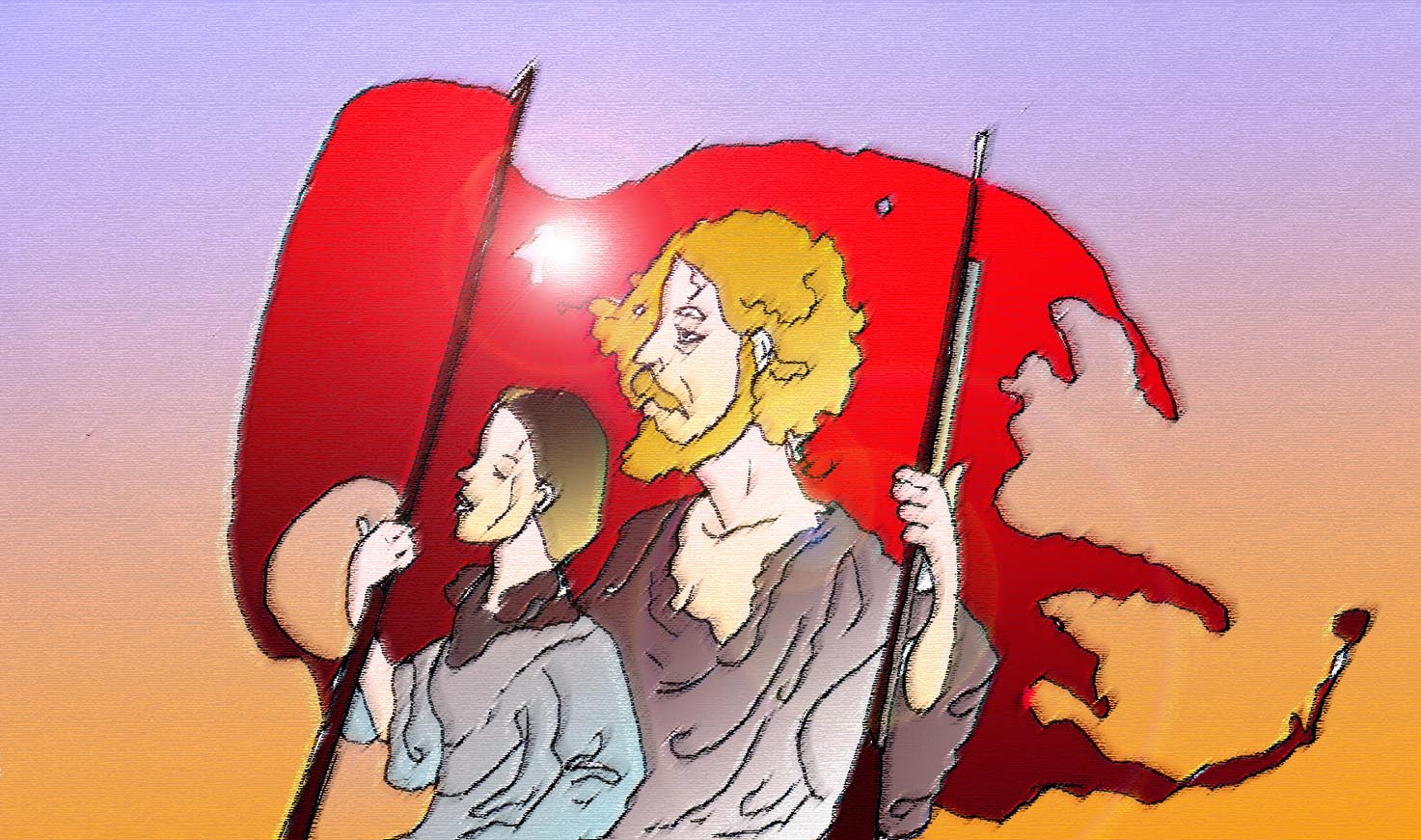









Del sangue rivoluzionario scorre nelle vene di Clara, ad onta del volto pallido e dell'apparente sua fragilità!
Balzac, in visita da Clara nel 1837, tornerà in patria col titolo del suo racconto: Gambara, suggeritogli da Clara - come il cognome della sua venerata famiglia materna.
Il grande Balzac è mandato a Clara da una comune amica, Fanny Sanseverino Porcia, la quale le scrive:
"De Balzac, con Teofilo Gautier, suo amico, viene a Milano.
Io lo raccomando alla mia gentilissima Chiarina e all'illustre Maffei.
Il celebre letterato francese conosca così le grazie, e ammiri l'ingegno italiano.
Egli troverà, ne sono certa, nella vostra casa, le cortesi accoglienze di cui ha diritto; ed io soddisfo, facendovi conoscere a lui, un orgoglio d'amicizia e di patria".
Gli eventi della vita Clara.
Perde giovanissima sua madre.
Il padre decide di mandarla nel rinomato collegio femminile di Milano, diretto da Mme Garnier.
Alle giovani fanciulle qui si insegna: religione, lingua italiana e francese, bel portamento, ballo, musica e ricamo.
Nel periodo del collegio, il padre le presenta un giovane trentino: biondo, alto, elegante, del cui talento poetico già parlava tutta Milano.
Il poeta Andrea Maffei.
Andrea dà un volto all'idea dell'amore.
Il matrimonio viene subito deciso.
Clara a diciotto anni esce dal collegio per andare dritta all'altare.
Via di Monte della Pietà n. 1 è la sua prima residenza da donna sposata.
Una casa dallo stile primo Impero, dove un tempo sorgeva un austero convento di monache francescane.
Suo marito lavora presso l'ufficio giudiziario, come impiegato di concetto ma il temperamento poetico e a volte bizzarro irrompe, anche a scapito della fragile contessina.
Trascurato il suo comportamento.
Un aneddoto lo può chiarire.
Festa da ballo, in casa della Fulvia Scotti.
Il ballo termina e Clara rimane sola... Andrea è andato via, dimenticandosi di sua moglie ...
Effettivamente suo marito sembra molto affetto da 'idilliche distrazioni'...
Quando il matrimonio è sull'orlo di una crisi, la nascita di una bambina sembra cementare l'unione tra i due coniugi.
Ma la tragica morte in culla spegne il sorriso della giovane madre.
Amici e amiche iniziano a frequentare assiduamente casa Maffei per consolare Clara nel suo lutto.
Andrea si dimostra più attento nei suoi riguardi, le porta in casa poeti, letterati in voga, artisti acclamati.
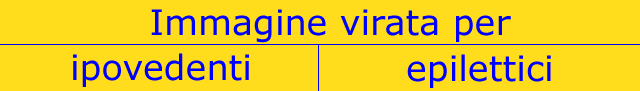
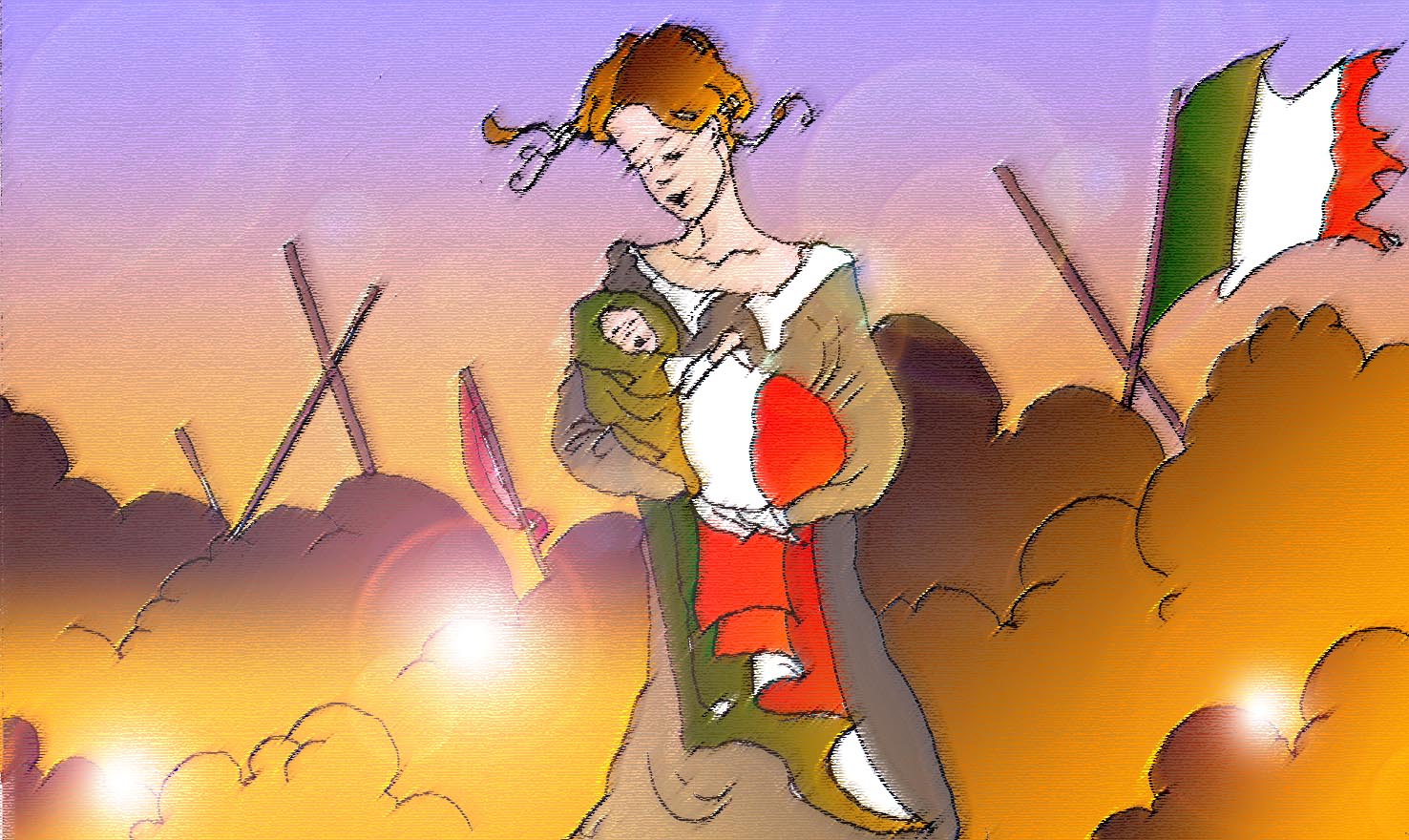









Anche suo padre le procura amicizie e conoscenze di rimarchevoli personalità. Si forma così una rete di persone nel salotto di casa Maffei. E' il 1834. Tra i fondatori di questo circolo: Tommaso Grossi, Massimo D'Azeglio, Francesco Hayez. Il galantuomo Tommaso è scrittore e poeta, amico di Alessandro Manzoni. Avvocato come formazione ma per lungo tempo si dedica alla letteratura per poi esercitare la professione di notaio. Massimo D'Azeglio, misurato politico e l'esuberante Francesco. La tristezza di Clara diluisce nell'esilarante racconto degli aneddoti autobiografici dell'Hayez, acclamato artista veneziano, caposcuola della pittura romantica. Francesco frequenta, quotidianamente o quasi, la casa della contessa, dopo aver lavorato tutto il giorno presso il suo studio in casa Repossi, immerso nel verde dei giardini, coi giganteschi platani. Il pittore è un amico ideale. Racconta del suo maestro Antonio Canova ma anche di tante sue monellerie studentesche, in ambiente romano. Riferisce che un giorno, calò dalle sue finestre due serpenti boa, assiderati ma vivi, che erano stati modelli per un cartone del Laocoonte. Li spenzolò sul capo di una processione di devoti salmodianti i quali, alla vista dei rettili, abbandonarono in modo scomposto la funzione religiosa! Letterati, artisti, intellettuali e aristocratici si mescolano nel salotto dei Maffei. Il calore della casa, si prepara ad accogliere i personaggi ed i temi più caratteristici del Risorgimento italiano. Cosa aveva di speciale il salotto Maffei? Beninteso: il salotto come luogo di discussione non è certamente una prerogativa della contessa! In Italia così come a Parigi, di salotti politici e letterari è pervaso il Settecento. Per non parlare, ancor prima, dei circoli Cinquecenteschi, dal calibro di corti - come ad esempio il salotto di Caterina Cornaro, con il suo castello in Asolo, celebrato dal Bembo, oppure la milanese casa della contessa Cecilia Gallerana-Bergamini. Ma tornando in epoca ottocentesca sono ancora noti i salotti di Mme Récamier, nel cui 'salon' si svolge il centro artistico romano, illustrato dal Canova. Fondamentale, ancora, il teatro alla Scala che funge da vero grande salone cittadino. Nonostante la storia dei salotti e della loro grande diffusione, la considerazione che può essere accordata a quello di casa Maffei non trova eguali. Ecco il suo ruolo, ad esempio, nel 1848. Alla vigilia delle Cinque Giornate, il salotto Maffei, nella casa in via del Giardino, è già fortemente patriottico. L'anno si apre con una grande tensione cittadina anti-austriaca. La lotta assume molti volti e si avvale di tanti mezzi. Un veicolo anche nel tabacco: i milanesi smettono di fumare i sigari, monopolio del Governo. Ma gli austriaci reagiscono. Il 3 gennaio per le strade del centro, sfilano diversi soldati armati di sigari fumanti, con aria di soddisfazione e di sfida... La gente li fischia per protesta. I soldati attaccano ed i tumulti finiscono nel sangue, a colpi di sciabole austriache. Gentildonne milanesi fanno a gara per soccorrere le vittime. Tra queste la contessa Maffei. Nell'alta società austriaca di Milano si disapprova l'eccidio e si teme la rappresaglia. La marea montante della rivolta rompe gli argini in marzo. Nei salotti si ospitano i feriti e si scioglie il piombo per formarne delle palle di cannone mentre il chimico Calderini prepara la polvere. Clara è mazziniana e non si allinea con le tendenze dell'aristocrazia patriottica lombarda che ripone le proprie speranze nella casa Savoia. Alla ricaduta del governo imperiale, nell'agosto 1848, alla luce dei fuochi incendiari di Radetzky che fa ritorno a Milano, fuggono diverse famiglie di patrioti. Anche Clara, con Carlo Tenca e la madre di lui, lasciano la città per trascorre del tempo a Locarno. Carlo è il suo nuovo compagno. Dal distratto Andrea ottiene una separazione consensuale Carlo è giornalista e fondatore del Crepuscolo (giornale prima mazziniano e poi cavouriano). E' un personaggio di spicco nel periodo delle Cinque Giornate di Milano. Clara, con il suo gesto di indipendenza dal marito, mostra un'eccezionale emancipazione che, in qualche modo, si riflette nel suo salotto, anche se non è l'evento che incide sulla vita culturale di Milano. Qui la contessa incontra il suo primo maestro di fede politica. Giuseppe Mazzini. Tra i due tuttavia non vi è intesa. Clara non diviene 'sorella' (come è solito chiamare Mazzini le signore trascinate nella sua sfera politica)... come se egli avesse già intuito che, di lì a poco, sarebbe nata una grande amicizia tra Clara e il suo rivale Cavour! Più avanti nel tempo. Dopo la Seconda Guerra di Indipendenza la signora Maffei riceverà, come attestato di stima, un ritratto autografato di Napoleone III, imperatore entrato vittorioso a Milano. Milano liberata, al tempo di Carnevale. Gli splendori di Milano nel 1860 sono senza pari. Le feste offerte dal primo sindaco, il conte Antonio Beretta, sono sfarzose così come nelle case dei salotti politici. Si accende l'entusiasmo popolare per Giuseppe Garibaldi il quale è a Milano ed è venerato come una divinità.
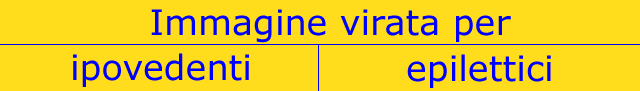
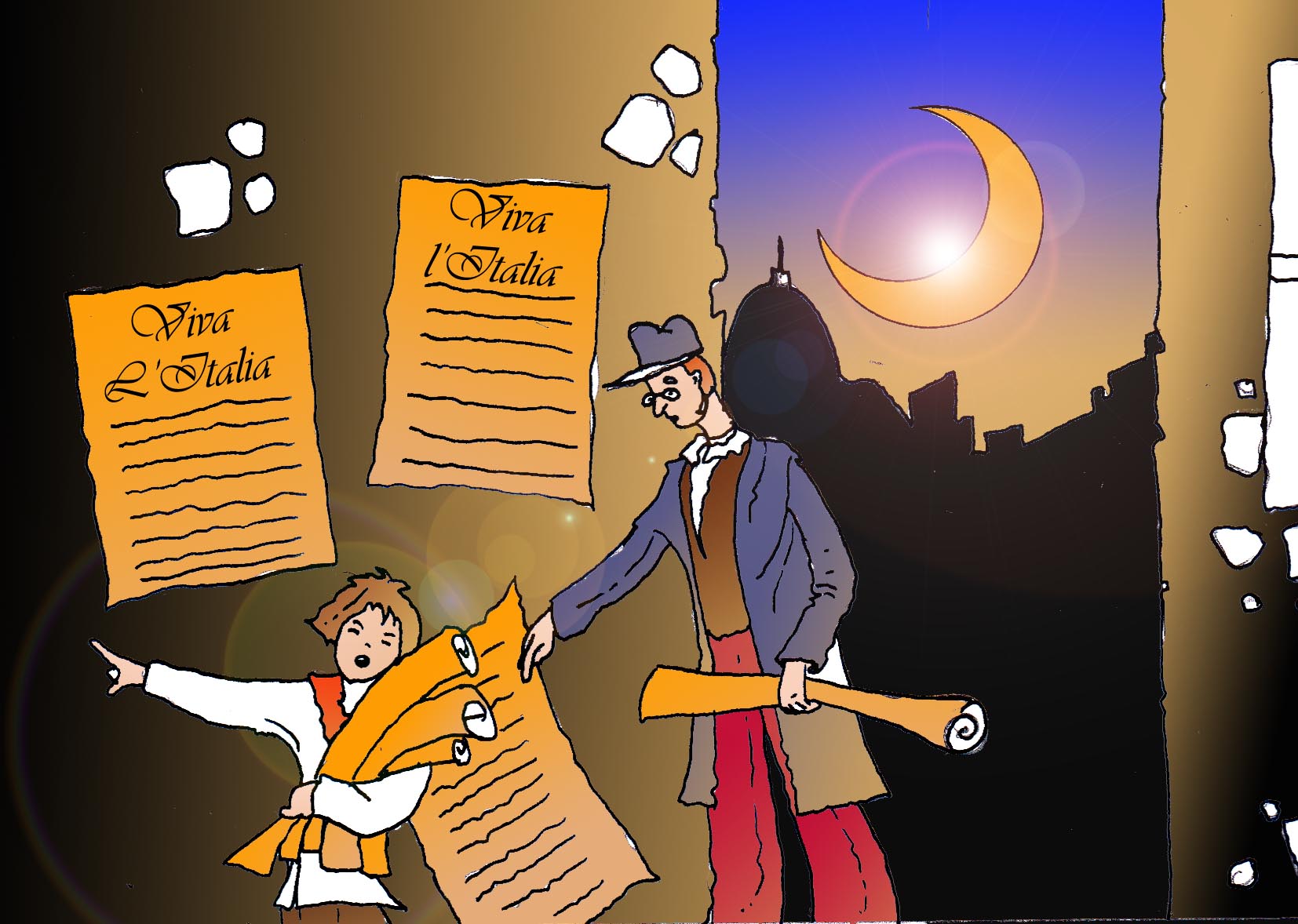









Si fa a gara per ospitarlo ma è per lo più in casa del ricchissimo patriota Giovanni Antona-Traversi, il cui palazzo non è lontano da quello Reale in cui si svolgono i segreti accordi tra Vittorio Emanuele II e l'Eroe dei due Mondi. Nella reggia, con l'annessione della Lombardia ai domini piemontesi, si è insediato il nuovo governatorato della città di Milano guidato da Massimo d'Azeglio - l'assiduo frequentatore di casa Maffei. In questi stessi anni Clara consolida la sua amicizia con Alessandro Manzoni. Tutte le domeniche, dopo la Messa, Clara è a casa del Manzoni, in Via Morone n. 1. Il Manzoni la riceve presso il suo studio austero, al pianterreno. D'inverno, davanti al caminetto, in lunghe conversazioni interrotte solo per il rattizzare del fuoco. In estate, in passeggiata nel piccolo giardino interno, su cui si affaccia lo studio. La contessa Maffei lo venera. Riporta in un quaderno i detti manzoniani più preziosi, emersi nei loro colloqui. Da queste memorie si traggono tante notizie. Sulla composizione dei Promessi Sposi, ad esempio. Il Manzoni le parla delle sue diverse ispirazioni attinte nei piccoli paesi lombardi, così come quando soggiornava presso il palazzo paterno, Il Caleotto, presso Lecco. Così sappiamo che l'Azzeccagarbugli è realmente esisto. Il personaggio riproduce fedelmente uno spilungone, allampanato leguleio di Lecco, noto per la sua cavillosità. Dei tanti aneddoti noti, circa l'amicizia tra Clara e il Manzoni, ve n'è uno particolarmente divertente che dimostra anche il comportamento lievemente nevrotico del poeta. Un giorno la contessa riceve l'omaggio di un mazzo di fiori veramente speciale. In uno slancio di generosità, per il piacere di condividere l'idea della bellezza con il suo amico illustre, lo manda subito al Manzoni. Il Manzoni, che a volte ha un atteggiamento stizzoso, non capisce il gesto dell'amica. Non sapendo cosa farsene di tanti fiori decide di regalarli a sua nuora, Giovannina Visconti. La giovane donna, analfabeta, ex-ballerina, appena vede il magnifico mazzo, dichiara con entusiasmo di volerlo inviare a Clara. Sicché la contessa si vede ritornare il dono floreale... Clara è molto brava a creare occasioni e relazioni tra le persone. A lei si deve il singolare incontro tra Manzoni e Verdi, il 30 giugno 1868. Poco dopo Verdi, dalla sua villa di Sant'Agata, scriveva a Clara: "Cosa potrei dirvi di Manzoni? Come spiegarvi la sensazione dolcissima, indefinibile, nuova, prodotta in me alla presenza di quel Santo, come voi lo chiamate?
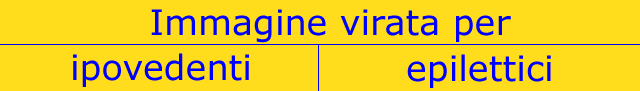
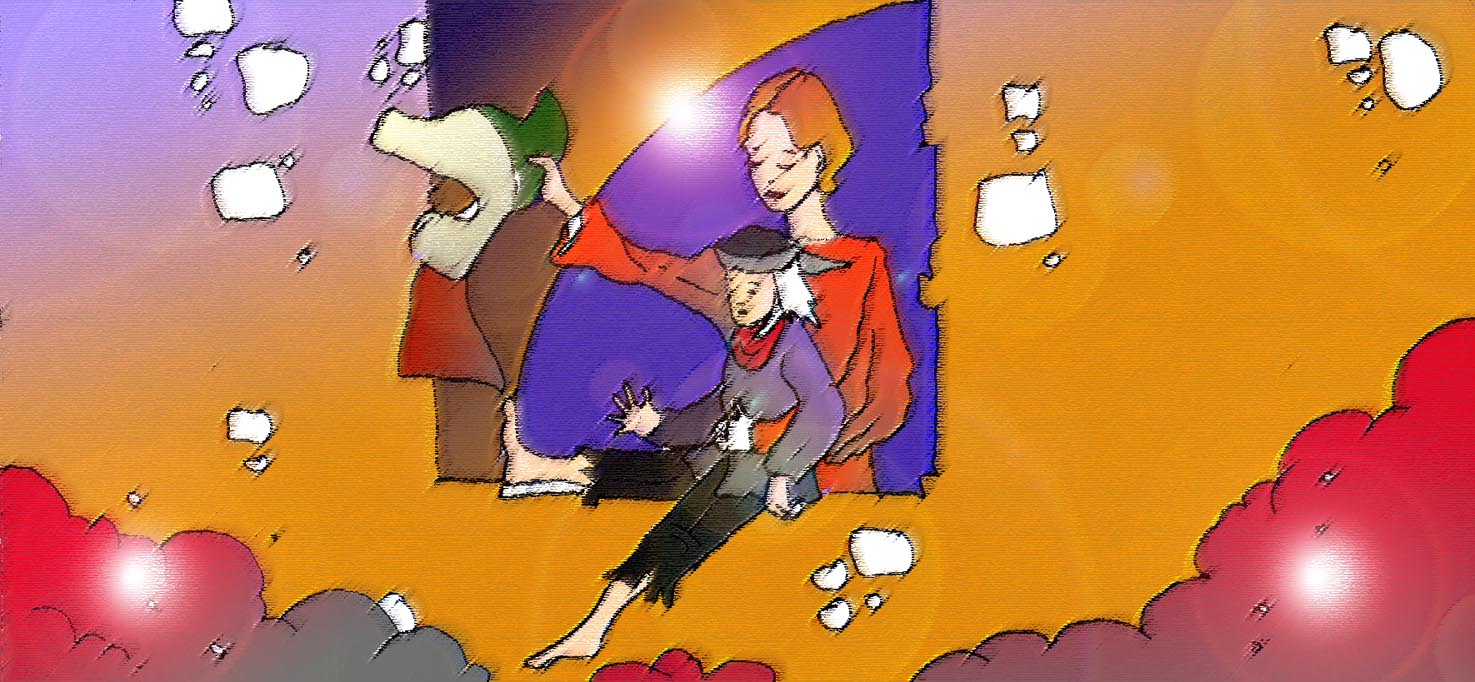









Io me gli sarei posto in ginocchio dinanzi, se si potessero adorare gli uomini... Quando lo vedete, baciategli la mano per me, e ditegli tutta la mia venerazione". E il 19 marzo del 1869, il Manzoni, per l'onomastico di Verdi invia su una sua carta di visita: "A Verdi - Alessandro Manzoni. Eco insignificante della pubblica ammirazione per il gran Maestro, e fortunato conoscitor personale delle nobili ed amabili qualità dell'uomo". E il maestro risponderà con l'omaggio più grande. Quella messa de requiem per la morte dell'illustrissimo letterato, il 22 maggio 1873. La morte del Manzoni fatalmente coincide, nel tempo, con la progressiva decadenza del salotto Maffei. A Clara rimane il conforto dell'altro grande amico, il maestro Verdi, nel pieno trionfo conquistato a Parigi. Ma per la contessa è un periodo difficile. Il suo grande amore, dopo la separazione consensuale da Andrea Maffei, il letterato patriota Carlo Tenca, si ammala e muore dopo lunga malattia, durante la quale Clara sospende le serate musicali per dedicarsi alla cura del suo compagno. Trascorso poco tempo muore anche suo marito Andrea, lontano da casa, in un albergo a Venezia, colpito da apoplessia. Il salotto risuona ora della solitudine della contessa. Il pianoforte è chiuso, il balcone del salotto è incolto e ricoperto da edera infestante. Clara seduta in poltrona, privata delle persone più care. Trascorre poco tempo tra la desolazione e la malattia mortale che colpisce Clara: una meningite che si aggrava di giorno in giorno. Dalla poltrona passa al letto. Le amiche che le assistono sono da lei percepite come ombre. E ombra è pure Verdi che verrà a trovarla proprio il giorno della sua fine. 13 giugno 1886. Esequie semplici, secondo il suo volere, ed un testamento nel quale vi sono indicati diversi lasciti ai poverelli che ha aiutato ed assistito per tutta la vita. Due anni dopo, gli amici, gli eredi e gli estimatori si riuniscono presso il cimitero monumentale di Milano per l'inaugurazione di un piccolo monumento. Un angelo che, appoggiato ad una croce, sparge dei fiori sulla tomba di Clara. Così si ricorda una donna buona e amante dell'indipendenza. E detto con le sue parole: "Io appartengo a me medesima, e solo io voglio essere giudice del mio operare'. E vinsi, almeno, la schiavitù delle cose convenzionali. È a duro prezzo ch'io acquistai tale libertà; pure è qualche cosa anch'essa quando non si vuole usarla che per bene".

